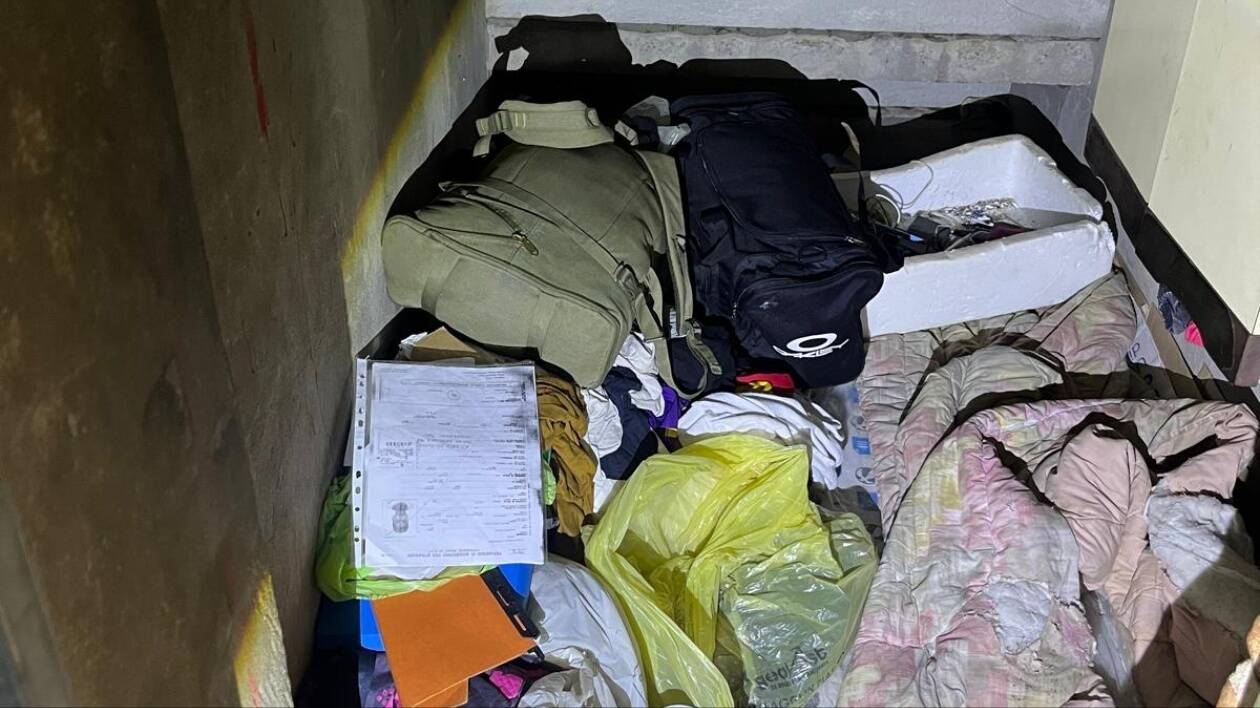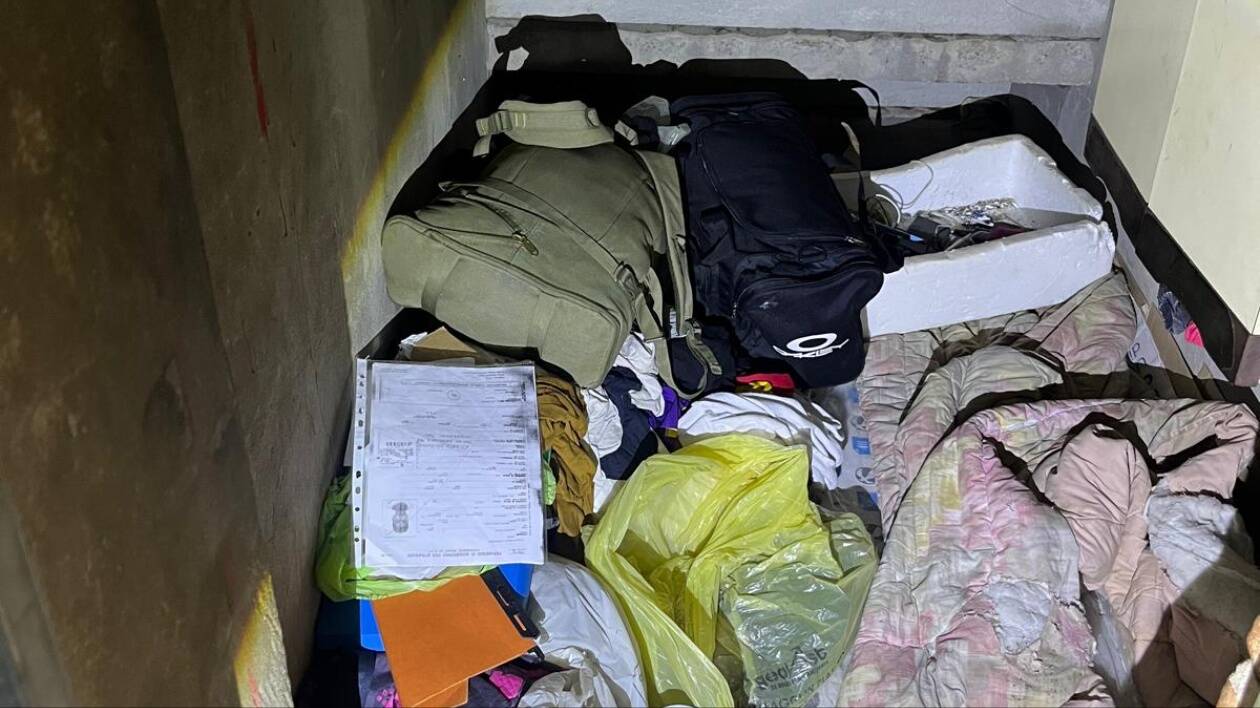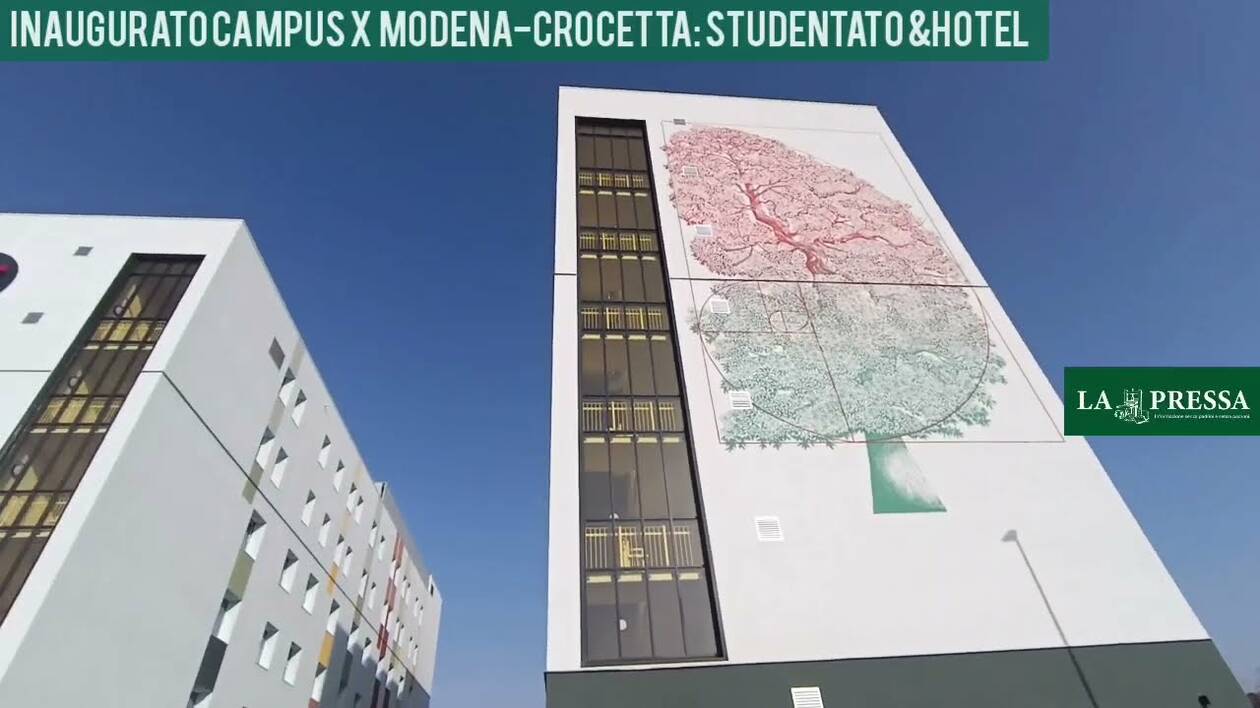Il primo elemento critico è la natura stessa del dato: non si tratta di nuovi posti di lavoro “netti” in senso sostanziale, ma di un saldo contabile tra assunzioni e cessazioni. In un mercato in cui i lavoratori entrano ed escono più volte dallo stesso impiego, il saldo positivo può convivere con una forte precarietà diffusa. Non a caso, nel 2025 le assunzioni complessive risultano in calo rispetto all’anno precedente, segno che la vitalità del sistema occupazionale non è affatto in accelerazione, ma piuttosto in una fase di rallentamento mascherato da stabilità statistica.
Particolarmente ingannevole è il riferimento al peso dei contratti a tempo indeterminato, che rappresenterebbero l’89% della crescita tendenziale. Questo dato, isolato dal contesto, suggerisce una robusta creazione di lavoro stabile, ma viene smentito dall’andamento dei flussi: le nuove assunzioni a tempo indeterminato diminuiscono sensibilmente e l’aumento del saldo dipende in larga misura dalle trasformazioni di contratti già esistenti e, soprattutto, dagli incentivi contributivi. Il forte incremento delle assunzioni agevolate dimostra che una parte consistente di questi rapporti di lavoro non è frutto di una domanda strutturale delle imprese, ma di un sostegno pubblico temporaneo che altera artificialmente le decisioni occupazionali.
Parallelamente, crescono le forme di lavoro più deboli e intermittenti. L’aumento dei contratti stagionali e del lavoro intermittente segnala una progressiva normalizzazione di rapporti discontinui, spesso mal retribuiti e privi di prospettive di stabilizzazione. Ancora più emblematico è il ricorso al lavoro occasionale, con compensi medi mensili che si attestano su importi difficilmente compatibili con un’esistenza dignitosa. Parlare di occupazione in questi casi significa forzare il concetto, perché si tratta piuttosto di micro-prestazioni che integrano redditi già bassi o sostituiscono forme di welfare sempre più ridotte.
Anche il capitolo della somministrazione, spesso presentato come indicatore di flessibilità “buona”, mostra segnali preoccupanti. Le assunzioni calano drasticamente, in particolare quelle a tempo indeterminato, mentre il saldo positivo complessivo è minimo e dovuto a dinamiche marginali.
Ciò che colpisce maggiormente, nel racconto ufficiale, è l’assenza totale di riferimenti alla qualità del lavoro. Non si parla di salari, di orari, di stabilità nel tempo, di possibilità di crescita professionale o di produttività. È una rimozione significativa, perché proprio su questi aspetti si gioca il vero futuro del mercato del lavoro italiano. Senza un miglioramento della qualità dell’occupazione, i numeri positivi rischiano di restare un esercizio statistico, incapace di incidere sulla vita reale delle persone.
Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un sistema che crea occupazione solo in apparenza, ma che in realtà consolida un modello basato su lavoro a basso valore aggiunto, incentivi pubblici permanenti e una crescente diffusione del lavoro povero. Celebrare questi risultati significa confondere la tenuta contabile con il benessere sociale e rimandare ancora una volta il confronto con il nodo centrale: non quanti posti di lavoro esistono, ma che tipo di lavoro viene offerto e a quali condizioni.